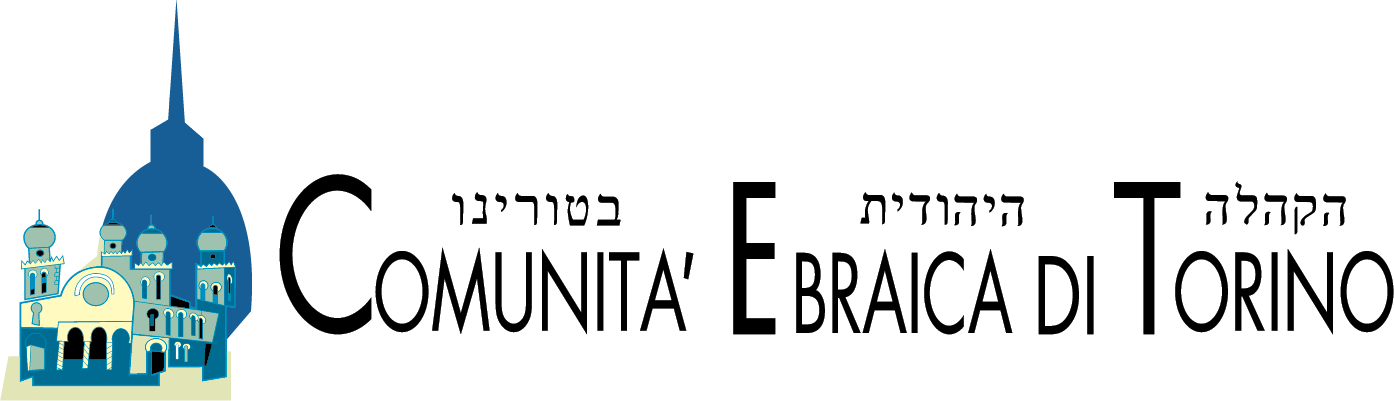Didattica
La memoria “degli” oggetti
#Oggetti #storia #memoria
Gli oggetti come testimoni: object based learning
Questo modulo propone riflessioni e attività a partire dagli oggetti conservati nei musei. Tracce preziose che affiancano quelle scritte e orali. Nell’object based learning è l’oggetto a essere al centro dell’esperienza di apprendimento. In questo modulo i docenti possono guidare la classe nella sperimentazione di questo approccio.
La tazza di Sylva Sabbadini

Questa piccola tazza, di proprietà del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, è appartenuta a Sylva Sabbadini, deportata e sopravvissuta alla Shoah.
Una giovane ragazza deportata e sopravvissuta con la madre; una tazza appartenuta forse ad un bambino o una bambina, non sappiamo chi, recuperata dalla madre di Sylva nei magazzini in cui erano stoccati tutti gli oggetti sequestrati all’arrivo ad Auschwitz e regalata alla figlia.
La tazza, infatti, è stata prodotta a Porsgrund, in Norvegia, da una fabbrica di ceramiche ancora oggi attiva; si tratta di una produzione databile agli inizi del ‘900.
Un oggetto quotidiano eppure prezioso, che per Sylva e la madre diventa simbolo di ritorno alla vita nonostante tutto; un oggetto che è anche memoria di un nome perduto, della bambina o del bambino arrivati ad Auschwitz portando con sé quella tazza. Un oggetto che grazie alla donazione degli eredi al MEIS continua e continuerà a testimoniare la sua storia.
Le testiomonianze di Sylva

Sylva Sabbadini (1950 - 1960 circa)
Archivio Fotografico CDEC
Sylva Sabbadini fu una delle 3 persone, rispetto alle 47 deportate da Vò Vecchio, a fare ritorno. Solo negli anni 2000 ha trovato la forza di raccontare la sua storia. Scomparsa nel giugno 2019, è sepolta al cimitero ebraico di Milano.
SCHEDA GUIDA PER INSEGNANTI
Questa scheda consente al docente di guidare la classe in un’attività partecipata che condurrà, tramite la storia della tazza di Sylva.
Scarica la scheda guida insegnanti
APPROFONDIRE
La convenzione di Faro
La testimonianza può essere contemporaneamente paragonata a un documento storico, una traccia utile a ricostruire un tassello della Storia, e a un bene culturale, un’eredità culturale così come intesa secondo la convenzione di Faro.
REMEMBR-HOUSE/CASE DI MEMORIA
L’approccio didattico alla Storia tramite oggetti e fonti documentarie è promosso anche dal progetto europeo di cittadinanza Remembr-House: dalle case e le cose alle esperienze di giovani cittadine e cittadini di oggi.